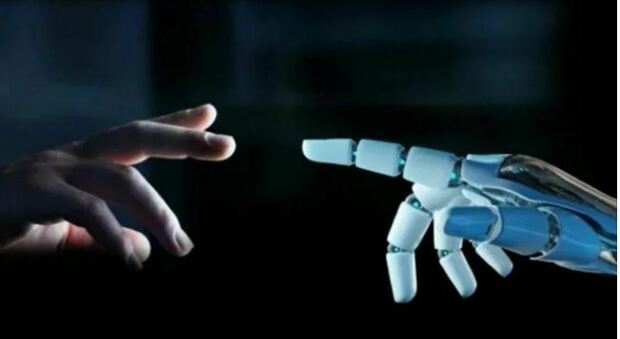Negli anni 70 arrivarono le prime calcolatrici elettroniche tascabili, qualcuno le ricorda? Display a 7 segmenti rossi, le più diffuse prodotte dalla Texas Instruments. Si sostituirono al regolo calcolatore, due righelli scorrevoli in scala logaritmica, subito agli esami scritti di ingegneria e in brevissimo tempo arrivarono anche nelle mani delle alunne e degli alunni delle scuole primarie. L’introduzione di questo semplice strumento non fu esente da discussioni e confronti di opinioni anche molto accese, il timore era di non educare al calcolo soprattutto i più giovani, ma così non è accaduto. Certo, come ripeto ai miei studenti, non “fidatevi” del risultato prodotto da un programma di calcolo in un computer, valutate la “congruità” del risultato, valutate se il risultato è plausibile con il contesto, se è corretto. Quando si usano strumenti automatici che semplificano alcune nostre azioni dobbiamo sempre mantenere la nostra capacità di analisi per comprendere se le azioni e le informazioni prodotte sono corrette ed utili.
La digitalizzazione
Soprattutto oggi, dove in seguito allo sviluppo esponenziale dei sistemi di calcolo, sempre più potenti, e alla digitalizzazione ormai pervasiva in ogni ambito, dall’economico al sociale e culturale, dobbiamo acquisire capacità di analisi e di valutazione di quanto ci viene proposto dai nuovi strumenti di Intelligenza artificiale. Sono strumenti capaci di fare meglio e più velocemente quello che noi sappiamo già fare, soprattutto perché riescono a utilizzare molti più dati e a elaborarli molto più velocemente di quanto possiamo fare noi. Più si utilizzano e più migliorano perché basati su algoritmi, insieme di regole codificate, capaci di proporre un apprendimento automatico, fanno meglio ciò che facevano prima, grazie al confronto tra quanto prevedevano e quanto i dati oggettivi esprimono. Se da un lato questo preoccupa, dall’altro si conferma che l’apprendimento codificato, un complesso modello matematico di dimensioni e strutture finite, un modello dei dati da cui ha appreso, produce quanto previsto. Il traduttore di testo da lingue diverse disponibile anche sul cellulare ne è un esempio.
Istantaneamente, mentre scriviamo il nostro testo in italiano, ci viene proposta la traduzione nella lingua scelta, perché addestrato su tantissimi testi di cui già si conosceva la traduzione, e sulle correzioni che noi introduciamo per migliorare la traduzione.
Chiare regole
Occorrono pertanto chiare regole di utilizzo, un attento controllo delle azioni che generano, livelli di sicurezza garantiti e tutela nell’utilizzo. Poi devono essere resi noti i dati utilizzati per l’addestramento che determinano la qualità delle risposte, un sistema intelligente è un modello dei dati utilizzati. Recentemente, la diffusione dei modelli linguistici di grandi dimensioni addestrati su una quantità grandissima di dati ha generato smarrimento e paura per la capacità di generare testo su precise indicazioni, mostrando una “apparente” capacità di ragionare e pianificare. Sono solo strumenti che possono aiutare a scrivere meglio e più velocemente una email, un nuovo programma di calcolo, ma non sono capaci di svolgere un qualsiasi compito intellettuale che ogni essere umano può sviluppare, come scrivere un romanzo o l’editoriale che state leggendo. Come ogni strumento dipende dal nostro utilizzo: un bastone può aiutare un anziano a camminare ma anche essere uno strumento di offesa.
*Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione
Facoltà di Ingegneria
Università Politecnica
delle Marche